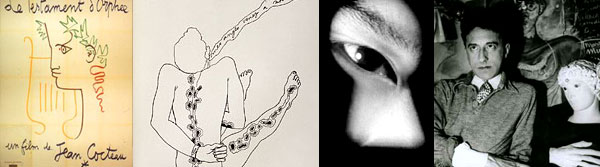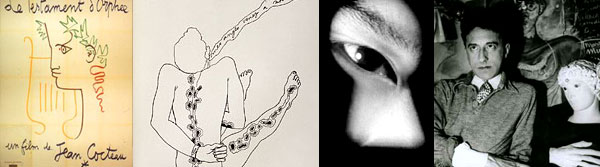Orphée dal palcoscenico allo schermo
E’ proprio in questa preghiera che si trova la traccia più evidente, ma anche più superficiale, della conversione che Cocteau attraversava al momento della stesura di Orphée. Nel resto dell’opera non si fa alcun riferimento esplicito alla religione cristiana, anche perché gli avvenimenti si svolgono in una Tracia stilizzata e modernizzata, ma pur sempre pagana. Del resto nel periodo della stesura di Orphée la fede di Cocteau cominciava già a vacillare, fino alla rottura definitiva con Maritain avvenuta nell’ottobre successivo. Nella preghiera finale si trovano alcuni spunti per un’interpretazione del significato globale del dramma che alla fine si rivela piuttosto falsata: se il cavallo di Orfeo è un’incarnazione del male, come è scritto, non sta in piedi la concezione positiva del soprannaturale, di quell’ailleurs che è la fonte primigenia della vera poesia. L’entità a cui è indirizzata la preghiera ci sembra inoltre coincidere, più che con il dio giudeo-cristiano, con il Seigneur inconnu dei già citati Sept dialogues, il cui santuario ha nome Poesia. Appare infine forzata l’interpretazione del personaggio di Heurtebise come angelo custode, essendo egli sì una figura angelica, ma il cui unico scopo è quello di aiutare Orfeo nel suo cammino iniziatico verso la poesia. Siamo quindi portati a pensare che questa scena finale sia come una sorta di refuso, ovvero un’ultima concessione alla fase religiosa che Cocteau stava finendo di attraversare.
Al di là dell’interpretazione cristiana del mito di Orfeo, che peraltro è stato rivisto varie volte in chiave cristico-ascetica, è comunque evidente che Cocteau riprende il mitologema orfico rispettandolo, ma pur sempre rimaneggiandolo a proprio uso e consumo; le innovazioni apportate all’intreccio tradizionale hanno proprio la funzione di avvicinarlo al sistema poetico-simbolico cocteliano. Fra queste, quella che per prima salta agli occhi è l’inserimento, accanto alla coppia mitica, di un terzo personaggio di discendenza ultramondana. Abbiamo già visto come nella poetica di Cocteau la figura dell’angelo rivesta un ruolo di capitale importanza, essendo egli un vero e proprio conduttore di poesia. Ma nel caso di Orphée questo suo ruolo viene particolarmente accentuato. Alcuni studiosi fanno notare che la funzione di Heurtebise all’interno della pièce è analogo al ruolo di Hermes in una delle attestazioni classiche del mito. Hermes nella mitologia greca ricopre, fra le altre, due funzioni precise: egli è il messaggero degli dei, è dunque l’anghelos per eccellenza, colui che fa la spola fra il mondo degli umani e quello degli immortali per stabilire un contatto fra i due. Inoltre, proprio per questa sua capacità di passare indistintamente da una dimensione all’altra, egli è colui che è incaricato, come San Michele nella religione cristiana, di guidare le anime dei morti nell’Ade. Per questa sua funzione di psicopompo egli partecipa dunque dei tre mondi: quello dei mortali, quello degli dei e quello dei morti. Ecco che Hermes rientra allora perfettamente nell’ideologia di Cocteau, e sembra quasi un personaggio di una delle sue poesie, apparentandosi al protagonista di “Visite”, a Léone, ed infine allo stesso Heurtebise.
Nella versione antica del mito in cui Hermes viene raffigurato accanto ai due sposi, egli ha il compito di sorvegliare le entrate e le uscite dall’Ade, e di guidarli nel loro contatto con l’altro mondo e con il soprannaturale in genere. La sua funzione coincide allora con quella di Heurtebise: anche lui è la guida di Orfeo, ma pure di Euridice, alle prese con un mondo differente dal loro, come è anche il guardiano dello specchio, ovvero della porta del regno dei morti. Non è un caso che egli sia presentato sotto l’aspetto di un vetraio, con le sue lastre di vetro legate sulla schiena, che vengono a rappresentare così un paio di ali stilizzate. Sempre secondo la logica per cui il soprannaturale discende in questo mondo assumendo un aspetto familiare ai suoi abitanti, l’angelo è un comunissimo vetraio ambulante, così come era un aiutante falegname nella concezione originaria della pièce. In più, l’elemento vitreo dello specchio, a cui l’angelo è qui fortemente correlato, è conservato nella dimensione terrena.
Lo stesso si dica dell’altra innovazione apportata da Cocteau, il cavallo che trasmette la poesia, di cui la radio nell’automobile della principessa costituisce l’omologo nella versione cinematografica. Questo animale è il veicolo che il soprannaturale ha scelto per manifestarsi ad Orfeo, ed è proprio l’animale che fra i primi è stato addomesticato dall’uomo, quindi il più familiare a lui dalla notte dei tempi. Orfeo subisce il fascino magico del cavallo, cioè dell’aldilà, e per assecondare questa fascinazione (Cocteau stesso parla di “envoûtement”) sacrifica la sua carriera affermata di poeta ufficiale per addentrarsi verso le origini stesse della Poesia. Ed è proprio questo che Euridice gli rimprovera:
Tu étais chargé de gloire, de fortune. Tu écrivais des poèmes qu’on s’arrachait et que toute la Thrace récitait par cœur. Tu glorifiais le soleil. Tu étais son prêtre et un chef. Mais depuis le cheval tout est fini.
Euridice, donna tutta terrena ed impermeabile al mistero (“Le mystère est mon ennemi. Je suis décidée à le combattre”), non riesce a capire come Orfeo possa rinunciare alla gloria che ha conquistato con le sue poesie per perseguire un altro genere di poesia, una poesia che non è di questo mondo e che per questo è affascinante, quel tipo di poesia che Cocteau pratica a partire da Le Potomak e che abbiamo appunto chiamato poesia orfica. Orfeo risponde ad Euridice:
Colle ton oreille contre cette phrase. Ecoute le mystère. […] Nous nous cognons dans le noir ; nous sommes dans le surnaturel jusqu’au cou. Nous jouons à cache-cache avec les dieux. Nous ne savons rien, rien, rien. « Madame Eurydice reviendra de enfers », ce n’est pas une phrase. C’est un poème, un poème du rêve, une fleur du fond de la mort.
|