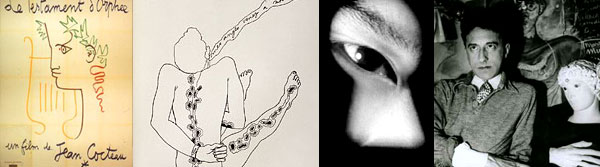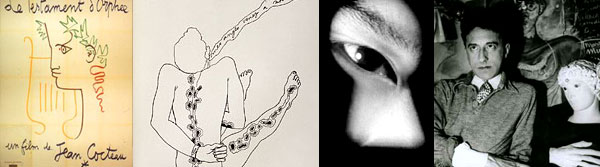Orphée dal palcoscenico allo schermo
Orfeo comprende ed assume in pieno la sua inferiorità nei confronti del soprannaturale. Si rende conto che il cavallo altro non è che un pezzo visibile dell’immensa “machine infernale” ordita contro di lui dagli dei. Riesce a capire che la poesia dettatagli dal cavallo è strettamente imparentata con il sogno e con la morte. Non per questo si arrende o cerca, come Euridice, di lottare contro il mistero, ma al contrario si accanisce ad indagarlo e si lascia assorbire nel gioco a nascondino con gli dei.
Non è chiara però l’interpretazione che bisogna dare alla figura del cavallo alla luce della preghiera finale che abbiamo già citato, in cui si parla dell’animale come di un’incarnazione del male, e di Euridice come della salvatrice di Orfeo. In effetti la questione è controversa: se è vero che esso rappresenta la poesia nella sua più alta accezione, cioè, lo ripetiamo, proveniente in modo diretto dall’aldilà, ci si domanda allora per quale motivo Heurtebise, anche lui creatura dell’altro mondo e per questo da considerare connaturato e complice del cavallo, aveva portato ad Euridice una zolletta di zucchero avvelenata ad esso destinata. Sono possibili alcune spiegazioni più o meno plausibili. Heurtebise potrebbe essere motivato ad eliminare il cavallo da un sentimento, in verità poco ultramondano, nei confronti di Euridice, contravvenendo così ai dettami del mondo a cui appartiene. Questa ipotesi potrebbe essere avallata alla luce della situazione di Heurtebise nella versione filmica: come vedremo in seguito, nel film Heurtebise confessa in effetti di amare Euridice. Ma proprio per questo essa ci appare forzata, influenzata a posteriori dalla visione del film. Seconda ipotesi: Coc-teau aveva bisogno di introdurre sul palcoscenico un mezzo con cui la Morte, nella scena sesta del dramma, potesse fare uscire di scena il cavallo. Anche questa ipotesi regge a fatica: la Morte poteva trarre a sé il cavallo in molte altre maniere, ed inoltre la scena in cui Heurtebise ed Euridice esitano nel somministrare il veleno al cavallo (scena terza) è troppo lunga ed insistita per essere un mero stratagemma scenico. Terza ed ultima ipotesi, Heurtebise vuole uccidere il cavallo perché Orfeo non è più considerato degno di ricevere i suoi messaggi; ma perché allora iniziarlo ai misteri dello specchio? Ed arriviamo alla spiegazione che ci sentiamo di fornire: il cavallo e i suoi messaggi non costituiscono che la prima fase del cammino di Orfeo verso la poesia; dopo avere percepito che la vera poesia non è quella che termina con la gloria, quella ufficiale, ma piuttosto quella il cui inizio e il cui fine non sono riscontrabili in questo mondo, il Poeta deve impegnarsi a raggiungere il mondo dei morti, vero e proprio alpha e omega della poesia, per potere attingere ad essa senza intermediazioni.
La terza ed ultima novità evidente che Cocteau inserisce nello schema del mito è la presenza di un quarto personaggio, che è la Morte in persona. Questo personaggio appare sul palco solo per una breve scena, al centro del dramma, ma la sua presenza è molto importante non tanto per il suo ruolo all’interno dell’economia drammaturgica, quanto piuttosto per la sua rappresentazione. In esergo al testo di Orphée, ecco come ce la presenta Cocteau:
La Mort est une jeune femme très belle en robe de bal rose vif et en manteau de fourrure. Cheveux, robe, manteau, souliers, gestes, démarche à la dernière mode. Elle a de grands yeux bleus peints sur un loup. Elle parle vite, d’une voix sèche et distraite. Sa blouse d’infirmière aussi doit être l’élégance même.
La Morte non ha niente a che vedere con l’iconografia classica che l’accompagna. Il tratto che la caratterizza è l’eleganza; questa eleganza è l’esteriorizzazione superficiale del fascino che essa esercita sul poeta. Il personaggio che raffigura la morte deve avere delle qualità che gli permettano di sedurre Orfeo e di legarlo a sé, tanto da fargli trascurare la sua vita terrena per incamminarsi verso di lei. Nella pièce, ma ancora più chiaramente nel film, Orfeo trascura il suo nucleo domestico sotto la fascinazione di questo personaggio attraente, tanto che si può quasi parlare di adulterio.
Questa rottura che opera Cocteau con la tradizione iconografica della morte non è dettata solamente dalla volontà di épater le bourgeois che è riscontrabile in buona parte della produzione teatrale (e non solo) degli anni Venti, ma si allinea perfettamente con il discorso che abbiamo già fatto sulle sembianze che assume il soprannaturale per apparire in questo mondo. La Morte spiega a Raphaël, uno dei suoi aiutanti:
Il y a encore une semaine, vous pensiez que j’étais un squelette avec un suaire et une faux. Vous vous représentiez un croquemitaine, un épouvantail… […] Mais, mon pauvre garçon, si j’étais comme les gens veulent me voir, ils me verraient. Et je dois entrer chez eux sans être vue.
Ancora una volta possiamo notare che gli abitanti dell’altro mondo usano venire presso i mortali, per così dire, in incognito. Come Heurtebise e come il cavallo, anche la Morte ha bisogno di mantenere celata la sua identità; per potere svolgere il suo lavoro, essa deve contravvenire alle aspettative degli uomini e mostrarsi in maniera del tutto differente da come questi se la rappresentano.
La Morte entra dunque in scena per compiere il suo lavoro in abito da sera, accompagnata da due aiutanti in camice da chirurghi, mascherina di garza e guanti di lattice. I personaggi escono fuori dallo specchio, secondo la norma per cui, come spiega Heurtebise ad Orfeo, “les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort va et vient”. I tre personaggi intraprendono un misterioso rituale per provocare il passaggio di Euridice dalla vita alla morte. La Morte indossa anche lei un camice sopra il vestito, lava le mani con l’alcool e infila dei guanti da chirurgo. Azraël mette in moto un rumoroso marchingegno che ricorda un elettrogeno e regola delle manopole seguendo le indicazioni dettategli dalla Morte. Questa intanto si è fatta bendare gli occhi e comincia ad eseguire una “gesticulation lente de masseuse et d’hypnotiseur autour d’une tête invisible”. Infine la Morte arrotola una bobina di filo che esce fuori dalla camera di Euridice, ad un’estremità del quale è attaccata una colomba; mentre i due aiutanti gesticolano in maniera bizzarra, la Morte taglia il filo e la colomba vola via. Dopo avere consumato questo rituale i tre scompaiono da dove sono venuti.
Azraël è alle dipendenze della Morte da molto più tempo di Raphaël, che appare impacciato ed ancora poco avvezzo alle regole del mondo dei morti. Fra la Morte, Azraël e Raphaël intercorrono gli stessi rapporti gerarchici che fra la principessa, Heurtebise e Cégeste nel film. Infatti tocca ad Azraël spiegare al suo collega:
La Mort, pour toucher les choses de la vie, traverse un élément qui les déforme et les déplace. Nos appareils lui permettent de les toucher où elle les voit, ce qui évite des calculs et une perte de temps considérable.
Ecco spiegata la funzione dei gesti e dei macchinari che vengono utilizzati per effettuare il trapasso di Euridice. L’apparecchio elettrico è una sorta di commutatore dimensionale, un equivalente tecnologico dello specchio, del sogno e dell’oppio: esso permette di aprire una breccia nel confine fra i differenti sistemi dimensionali mettendoli così in comunicazione. Cocteau qui dimostra lo stesso interesse per un certo filone scientifico che si manifesterà poi più chiaramente nel Journal d’un inconnu.
|