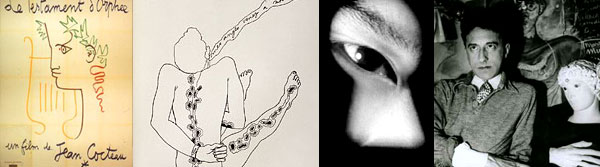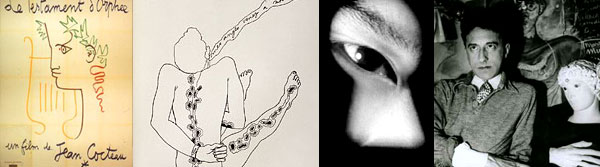Orphée dal palcoscenico allo schermo
Ancora una volta, dunque, ci troviamo a postulare l’esistenza di due mondi, non isolati, ma suscettibili di interscambi. In una poesia intitolata “Le rythme grec” troviamo:
Hommes et dieux habitent le même immeuble
Et parfois ils se rencontrent dans l’escalier.
Proprio come i vivi e i morti, gli uomini e gli dei coabitano nello stesso spazio, pur senza rendersene conto. La figura della scala che permette di andare e venire da un mondo all’altro, collegata con l’aneddoto biblico del sogno di Giacobbe, è in questo caso l’equivalente simbolico dello specchio: entrambi permettono la compenetrazione fra i due sistemi dimensionali. Ma ancora:
Rien n’est du crime d’Oreste
Vu sauf près d’un piscine.
A Mycènes l’acte reste
Par lequel il assassine.
De cette étonnante scène
S’acharne un tableau vivant.
Nous le vîmes à Mycènes
Après je veux dire avant.
In queste due strofe Cocteau sottolinea uno degli aspetti principali del mito, che è quello di dilatarsi al di fuori dei limiti spazio-temporali. “Queste storie non avvengono mai, ma sono sempre”. Alla luce degli aspetti della poetica cocteliana che abbiamo enucleati, è naturale che Cocteau si accosti con interesse alla mitologia, che gli permette di appropriarsi di qualcosa che, come l’angelo, come la poesia e come il film, continua a vivere senza preoccuparsi dei limiti imposti dalle dimensioni. “Pour Cocteau, le mythe est avant tout la vérité d’un univers intégral où régnait, en des temps immémoriaux, l’unité absolue entre les dieux, les êtres et les choses”.
Prima di affrontare direttamente la versione offerta da Cocteau del mito di Orfeo e di Euridice è interessante analizzare brevemente un’opera che precede di poco Orphée, e che è la prima pièce, in ordine cronologico, in cui l’autore abbia esplicitamente ripreso un mito antico: Antigone. Rappresentata per la prima volta il 20 dicembre 1922 a Parigi, al Théâtre de l’Atelier, quest’opera è presentata come una traduzione o una contrazione della tragedia di Sofocle:
C’est tentant de photographier la Grèce en aéroplane. On lui découvre un aspect tout neuf.
Ainsi j’ai voulu traduire Antigone. A vol d’oiseau de grandes beautés disparaissent, d’autres surgissent ; il se forme des rapprochements, des blocs, des ombres, des angles, des reliefs inattendus.
Peut-être mon expérience est-elle un moyen de faire vivre les vieux chefs-d’œuvre. A force d’y habiter nous les contemplons distraitement, mais parce que je survole un texte célèbre, chacun croit l’entendre pour la première fois.
In questa breve presentazione del suo dramma, Cocteau spiega il motivo di una nuova versione del mito di Antigone: l’inserimento dell’intreccio antico nel mondo moderno provoca la compenetrazione di due universi distinti e l’abolizione delle dimensioni temporali. Da questa operazione deriva una nuova fruizione del mito, che rimane immutato benché inserito in una temperie culturale del tutto differente.
Ma il mito riesce a conservare la sua forza ed il suo valore nel tempo proprio perché si adatta al nuovo contesto in cui viene inserito. Alcune note di regia di Cocteau sono illuminanti in proposito:
L’extrême vitesse de l’action n’empêche pas les acteurs d’articuler beaucoup et de remuer peu. Le chœur et le coryphée se résument en une voix qui parle très haut et très vite comme si elle lisait un article de journal. Cette voix sort d’un trou, au centre du décor.
Naturellement, aucune figuration n’escorte les personnages.
La caratteristica fondamentale di questa Antigone è la velocità (e sarebbe inutile insistere sul concetto di velocità come tratto caratterizzante della civiltà moderna), insieme ad una sorta di anonimato al quale sono costretti i personaggi: ne deriva un effetto di banalizzazione del mito. La tragedia della stirpe di Edipo viene ridotta ad un fatto di cronaca; il coro dei vecchi tebani si riduce alla voce di uno speaker. In questo non è da vedere una volontà dissacratoria, quanto piuttosto la dimostrazione della validità universale dei valori che la fabula mitica mette in gioco. Cocteau, contrariamente per esempio ad Anouilh, non crea con questo dramma una nuova versione del mito, e nel suo caso non si può parlare di mito letterario nel senso in cui lo intende Albouy. Infatti l’autore parla piuttosto di contrazione: come faceva nello stesso periodo con Roméo et Juliette, egli si limita ad eliminare il superfluo e a mettere in rilievo la struttura emotiva profonda che intrecci narrativi di questo calibro portano in sé. Nella versione originale di Sofocle, il primo stasimo della tragedia è un brano di altissimo lirismo, in cui i cittadini di Tebe celebrano la grandezza dell’uomo e le sue vittorie sulla natura. In Cocteau, ecco cosa resta di tanto slancio:
L’homme est inouï. L’homme navigue, l’homme laboure, l’homme chasse, l’homme pêche. Il dompte les chevaux. Il pense. Il parle. Il invente des codes, il se chauffe et il couvre sa maison. Il échappe aux maladies. La mort est la seule maladie qu’il ne guérisse pas. Il fait le bien et le mal. Il est un brave homme s’il écoute les lois du ciel et de la terre, mais il cesse de l’être s’il ne les écoute plus.
In questo andamento paratattico e monotono non resta niente del sapore epico del testo di partenza. La tragedia di Antigone per Cocteau si abbassa al livello della banalità quotidiana, pur restando una validissima meditazione sul conflitto fra ragion di stato e leggi non scritte. Come l’angelo può scendere fra i mortali, così il mito può insinuarsi nel quotidiano. Analogamente, Orfeo ed Euridice sono rappresentati da Cocteau come una coppia in crisi, ovvero quanto di più banale possa esistere nella civiltà contemporanea.
Fra i miti che la modernità ha ereditato dai Greci, il mito di Orfeo è comunque quello da cui Cocteau è rimasto più affascinato, per non dire ossessionato, e che ha trattato in vari momenti della sua vita. Al cantore tracio sono dedicati un dramma, un film, un balletto, una quantità quasi incalcolabile di disegni e pitture, ed a lui si fa spesso riferimento nell'opera poetica. Del resto è normale che un poeta come Cocteau, che tale si è voluto e si è dichiarato anche quando si trovava dietro una cinepresa o quando impugnava un pennello, abbia subito la tentazione dell'identificazione con Orfeo, il Poeta per antonomasia. Bisogna inoltre notare che la favola di Orfeo mette in gioco alcuni temi che sono, come abbiamo visto, centrali nell'universo cocteliano: la morte e la resurrezione del poeta, l'esistenza di due mondi speculari, il passaggio dall'uno all'altro dei due mondi. Cocteau stesso riconosce:
Ma démarche morale étant celle d’un homme qui boite, un pied dans la vie et un pied dans la mort, il était normal que j’en arrivasse à un mythe où la vie et la mort s’affrontent.
|